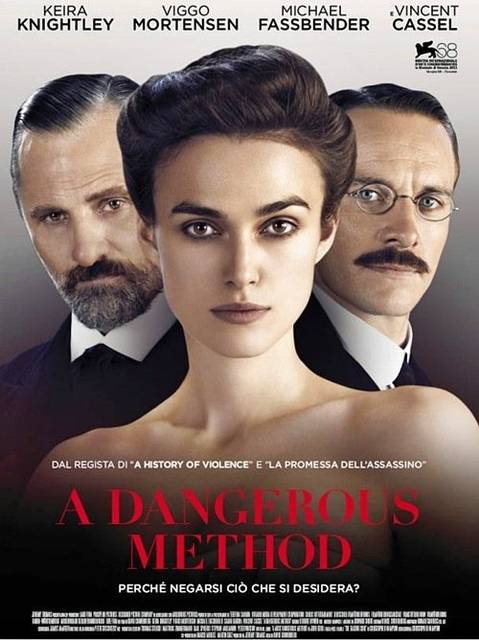Il capitale umano di Virzì, la realtà triste dietro le maschere
Ci sono film che ci si pente d’aver visto e film che dovrebbero essere guardati a priori. Il capitale umano (2014), ultima opera di Paolo Virzì, non solo è uno di quei film da non perdere ma è uno di quelli da consigliare alle generazioni fin dagli anni del liceo. Se si dovesse fare un paragone, fra questa pellicola e la storia del cinema, forse, si potrebbero citare Tra le nuvole (2009), di Jason Reitman, L’avvocato del diavolo (1997), di Taylor Hackford e, naturalmente, Wall Street (1987), di Oliver Stone. Ma Il capitale umano, d’altra parte, non è solamente un film sull’eccesso o sulla decadenza morale. Virzì ci parla pure di mediocrità intellettuale, di volgarità umana (quella che da troppo tempo, ormai, attanaglia il nostro Paese) e, soprattutto, di solitudine.
La vicenda del film, che si rivela essere una vicenda-thriller, si snoda attraverso una triplice prospettiva: quella dei tre protagonisti principali. Tutti e tre sono accumunati dall’essere benestanti, rappresentanti di quella media e alta borghesia brianzola senza scrupoli di sorta. C’è Dino Ossola (Fabrizio Bentivoglio), titolare di un’agenzia immobiliare che non esita a dichiarare il falso pur di cambiare la propria condizione economica, c’è Carla Bernaschi (ottima l’interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi), madre inibita, totalmente incapace di esprimere la propria personalità e la propria volontà e c’è Serena Ossola (Matilde Gioli), figlia disinibita, studentessa, vittima (e complice) di un ambiente eticamente degradato. Arrampicatori sociali, dunque, rampolli allo sbando, personalità violente e depresse: una galleria di mostri che avrebbero fatto gola alla penna di David Foster Wallace o di Don DeLillo, che sono stati partoriti, invece, da quella di Stephen Amidon.
Il film, infatti, è un adattamento di Human Capital (2004), ambientato in Connecticut. La Brianza come il Connecticut? Forse, o forse peggio. I personaggi del film sono totalmente narcotizzati dagli eccessi della loro vita, basata sull’apparenza, sull’avere e sul potere: Virzì è abile nel catturarne i vizi con garbo. Ma questa leggerezza non tradisce indulgenza: svela, al contrario, la banalità del peccato. Un peccato concepito come normale, dal quale, però, non vi è ritorno. Emblema di questo degrado è il Suv: in questa macchina di lusso si concentra l’ebbrezza dello sfarzo e, al contempo, una triste parabola di morte. È proprio il Suv, difatti, ad essere la miccia d’innesco dell’intera vicenda. Una vicenda che non lascia spazio alla redenzione, né al lieto fine. Non s’inganni il pubblico: il sorriso finale di Serena è, ormai, un sorriso corrotto, proprio di una persona ormai divorata dal baratro dell’esistenza. Un finale amaro quindi, un finale alla Donnie Brasco (Mike Newell, 1997).
Ma cosa si intende per “capitale umano”? Con “capitale umano” si intende l’insieme di conoscenze, capacità e competenze proprie di un individuo, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi sociali ed economici. E proprio di questo parla il film. I vari personaggi, infatti, identificano (e riconoscono) loro stessi in base al valore economico e alla rilevanza sociale che incarnano. Palese come il regista, attraverso una narrazione impalpabile, punti il dito contro una certa realtà, già anticipata, per certi versi, da La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino. Una realtà che si presta, sempre più, alla farsa e che il nostro Paese non può più tollerare. Sintomatico, a tal proposito, come, verso la fine del film, due dei protagonisti principali, rovinati dal loro eccesso, si trovino in un teatro destinato alla distruzione. Insomma, Virzì sembra sussurrare come lo spettacolo stia per finire. Non solo quello intrapreso dai suoi personaggi di cellulosa. Un film da vedere, con buona pace di alcuni sindaci brianzoli.